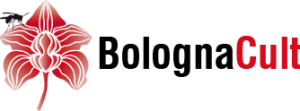Cosa: incontro e presentazione di Feel Free di Zadie Smith
Nelle giornate di domenica e lunedì, Zadie Smith, una delle scrittrici più di talento e influenti del momento, è stata prima ospite al festival di Internazionale a Ferrara, e in seconda battuta invitata all’interno di un incontro organizzato da Gender Bender qui a Bologna. In entrambe le occasioni le considerazioni intorno alla sua ultima fatica letteraria sono andate sfociando nell’attualità di cui la sua scrittura si nutre fortemente.
Zadie Smith ha scritto diversi romanzi memorabili, specchio di una società polifonica, più dissonante che corale. Ha sedotto milioni di lettori con punti di vista multipli che si spostano da un personaggio all’altro, in una Londra popolare e centrifuga in cui i suoni di ogni accento, dal cockney al giamaicano, che vengono magistralmente riportati in forma scritta.
Dire che i suoi romanzi parlano di multiculturalità sembra riduttivo, perché le sue pagine creano trame narrative intorno alle relazioni familiari, di amicizia, di coppia, e di quanto queste vengano effettivamente influenzate dai fattori dell’identità, del background culturale, delle ambizioni personali e, non ultime, delle politiche sociali ed economiche. È evidente inoltre la sua magnifica ossessione per gli anni ’90, periodo in cui ambienta molte delle sue storie, in cui è tangibile un’atmosfera pre-Facebook che molti di noi ricordano e alla quale Smith sembra essere particolarmente affezionata.
Partendo dal titolo del suo libro, Feel Free (ed. Big Sur), seduta accanto alla sua traduttrice e interprete ufficiale Martina Testa, nella cornice dell’incontro bolognese Smith racconta di un intervistatore che di recente le ha candidamente chiesto: “Feel free to do what?” (“Libera di fare cosa?”).
Più che di fare, Smith invoca attraverso questo titolo la libertà di essere incoerenti, conflittuali, ambivalenti: tutte cose che si fa fatica a esprimere pubblicamente. La conversazione con l’autrice si è poi sviluppata attorno al tema centrale dell’identità e le sue varie declinazioni. Se da un lato esiste il bisogno di nominare tutto ciò che finora è stato relegato in un calderone di emarginazione lessicale e sociale, dall’altro le etichette rischiano di bloccare la possibilità di stringere alleanze tra individui dalle diverse esperienze.
La stessa Smith ha ammesso di essere stata più volte invitata a non occuparsi di questioni ‘da afroamericani’ perché la sua esperienza è diversa, essendo cresciuta in Inghilterra. O, ancora, le è stato spesso intimato di starsene zitta, col pretesto che la sua pelle non fosse abbastanza scura per parlare a nome di altri.
Smith crea anche un momento di leggerezza quando parla del marito (il poeta irlandese Nick Laird), il quale, prima di trasferirsi negli Stati Uniti, non aveva mai avuto coscienza del fatto di essere un maschio bianco cis-gender. Inconsapevolezza che, in una società come quella americana, non sembra potersi dare: “È come se le persone bianche ed eterosessuali non avessero un’identità, come se esistessero e basta, il che è assurdo. Ma anche sentirsi ricordare costantemente la propria identità, in effetti, è estenuante”, ammette, ripensando alla sua esperienza di persona di colore cresciuta in una società occidentale.
Smith va avanti parlando dell’atteggiamento di chi tratta le identità come qualcosa di materiale, qualcosa che si ha, che si sfoggia contro chi invece non ce l’ha; racconta di una ragazza di colore che, durante un suo intervento a un festival di letteratura, si è alzata e le ha chiesto “Why are you talking to all these white people?”: “Perché ti rivolgi a tutti questi bianchi?”. Questo è precisamente uno degli atteggiamenti che Smith reputa pericolosi e autolesionisti. Arroccarsi sulla propria esperienza personale come modo per chiudere qualsiasi discussione è di fatto controproducente, divide dal perseguire un obiettivo potenzialmente comune e impedisce un processo di empatia che dovrebbe aiutare a unire le persone, a rendere ricco un dialogo in cui diverse esperienze sono una risorsa, e non una barriera.
Lei stessa nei suoi saggi ricorre spesso all’esperienza personale, non come bandiera ma come occasione di confronto, innescando riflessioni più ampie sulla realtà globale. Dalle popstar di ieri e di oggi, ai dipinti del ‘700, all’essere figlia e madre, ogni situazione è un pretesto valido per riflettere sulle cose del mondo. Non solo Smith è una scrittrice di talento, ma dimostra di essere estremamente cosciente del peso che ha una voce ascoltata e influente come la sua, misurandosi con forme di scrittura che non siano puramente fiction. I saggi e gli articoli permettono effettivamente di instaurare un legame con i lettori, a cui è consentito entrare in contatto con il modo di pensare di un’autrice che non si barrica dietro la sua produzione artistica ma che, al contrario, invita a interpretare insieme a lei la realtà che ci circonda attraverso le sue suggestioni.
Quello che colpisce è il modo sommesso che ha di parlare, pesando ogni singola parola pur essendo sicura del suo ragionamento. Non si rivolge al pubblico col piglio dell’attivista oratrice, e non parla nemmeno del libro in sé, ma si esprime con un senso di responsabilità e urgenza di temi di cui è impossibile non parlare in questo momento, ma che forse a causa della loro complessità, a volte vengono lasciati ai margini della discussione pubblica.
Con la sua opera Zadie Smith chiede implicitamente a lettori e ascoltatori di sentirsi liberi di stringere legami con chi ha un’esperienza diversa dalla propria, di essere ambivalenti e di essere alleati. Un invito che al tempo stesso è una missione, la missione di sentirsi liberi.