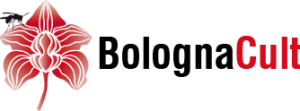Cosa vi siete persi quando il cineasta ha annullato l’appuntamento in Cineteca
Cosa: cronaca dall’incontro con Béla Tarr
Dove: Head – Haute Ècole d’Art et de Design, Ginevra
Quando: novembre 2014
di Aldo Trucchio
Il mio primo ricordo del cinema di Béla Tarr risale a una notte di molti anni fa. Era Fuori Orario, ovviamente, che mandava in onda Satantango. Rimasi incantato a guardare i lunghissimi piani sequenza…
Cosa vi siete persi quando il cineasta ha annullato l’appuntamento in Cineteca
IN BREVE Cosa: cronaca dall’incontro con Béla Tarr Dove: Head – Haute Ècole d’Art et de Design, Ginevra Quando: novembre 2014
Era febbraio quando Béla Tarr, probabilmente il più grande autore di cinema in circolazione, bucò il preannunciato e attesissimo incontro alla Cineteca di Bologna. A Ginevra, invece, c’è andato davvero.
di Aldo Trucchio
Il mio primo ricordo del cinema di Béla Tarr risale a una notte di molti anni fa. Era Fuori Orario, ovviamente, che mandava in onda Satantango. Rimasi incantato a guardare i lunghissimi piani sequenza che lo aprono, quello circolare intorno alla fattoria – le vacche che escono dalla stalla, i muri sbiecati dal vento –, e quello statico che lo segue – una finestra, il sorgere del sole, una donna che si sveglia e si lava. Non finii di vedere le sette ore di film restanti, lo ammetto, tuttavia quella notte mi è tornata in mente ascoltando il dialogo del cineasta con Jean Perret e Sophie Perrer alla Head (Haute Ècole d’Art et de Design) di Ginevra, lo scorso 29 ottobre. Mi aspettavo un vecchio saggio ieratico, con una lunga barba bianca, e invece quello che mi trovo davanti è un tipo divertente, poco attento alla forma, che fa continuamente battute nonostante il “fucking english” in cui è costretto a esprimersi.
I suoi ospiti hanno scelto di inframmezzare le domande con la proiezione, sul grande schermo che li sovrasta, di frammenti tratti dai suoi film; e lui s’incazza subito: un film è un processo, se si mostra un pezzo del processo isolato dal resto, non si capisce niente. “Se proprio dovete far vedere qualcosa, fate vedere l’inizio dei miei film”, chiede. L’inizio, spiega, è un patto con gli spettatori. Restate una ventina di minuti e poi decidete se uscire: io sono assolutamente onesto. E come dargli torto? Passo in rassegna i suoi incipit: la corsa folle del vetturino che apre The Turin Horse, la finestra di Damnation, la nave di The Man from London e, soprattutto, la mia scena iniziale preferita, la sublime danza celeste degli ubriaconi che apre Werckmeister Harmonies.
Ma è già tempo di un altro filmato; e lui s’incazza ancora di più: “Almeno fate vedere quando ballano! A me piace quando ballano!”. Alzo la mano per chiedergli, appunto, del suo noto amore per le scene di danza, ma Tarr si sta già incazzando ancora una volta: “Così non arriviamo da nessuna parte, mi fate troppe domande, e tutte slegate tra loro!”. Abbasso la mano. “Noi vogliamo sapere tutto sul suo cinema”, dice gentile Jean Perret. “E allora questa intervista dovrà durare 34 anni, perché io ho fatto film per 34 anni” è la risposta. (Il piano sequenza è vita, il montaggio è morte: mi viene in mente questa frase, ma non dove l’ho sentita, né chi l’ha detta). “Ricominciamo daccapo”, sbuffa il grande ungherese.
“I film che vedevo al cinema da ragazzino non mi piacevano”, racconta. Colori falsi, suoni falsi, recitazione esasperata: “per me erano tutti la stessa cosa”, esagera forse un po’. Allora decide di farne uno anche lui. Senza budget, un gruppo di amici, una 16mm sulla spalla, rigorosamente in bianco e nero: Family Nest, uscito nel 1979, non ha una vera storia, ma mette in scena le relazioni tese fra tre famiglie, costrette a coabitare in un piccolo appartamento, in attesa di quella sistemazione migliore che il socialismo reale garantisce a tutti, ma coi suoi tempi: “due, tre anni almeno”, dice un impiegato nel clip che ci viene prontamente somministrato.
Il film per intero lo vediamo il giorno dopo nella sala Langlois del glorioso Grütli. Tarr lo introduce con una sola frase: “queste persone vi possono fare schifo, ma sappiate che io le amo, tutte”. L’influsso della libertà espressiva della nouvelle vague è evidente, dei primissimi Godard e Resnais, ma il film è soprattutto claustrofobico, asfissiante fino all’insopportabile. La camera resta fissa sui volti, anche nei silenzi o quando va fuori fuoco. E davvero i protagonisti fanno schifo: bevono e fumano tutto il tempo, sudano, litigano, si insultano, vomitano, si ricattano, fanno persino piangere i bambini. L’approccio con le donne è sempre violento, mariti e mogli si tradiscono con uguale disinvoltura. La scena in cui vittima e carnefici di una violenza sessuale si ritrovano al bar a bere assieme non manca di turbare gli spettatori, che ne chiedono conto al regista, dopo il film: “avrebbe dovuto condannare chiaramente quegli uomini”, sibila una donna anziana. Il film sortisce ancora il suo effetto, Tarr ne è evidentemente contento, ma si limita a dichiarare: “io non giudico mai, il mio è un puro esercizio di empatia e tenerezza”.
Family Nest è una provocazione, un’opera di rottura, un’evidente metafora chiamata a rappresentare un paese misero e chiuso su se stesso, tuttavia la censura non lo tocca e diviene un grande successo, anche commerciale. Il giovane Tarr voleva cambiare il mondo, voleva mostrare che gli uomini si comportano male perché costretti dalle circostanze, ma già durante le riprese inizia ad avere dei dubbi. “Non siamo solo determinati dalla società, ma la determiniamo a nostra volta”, riflette, e lì lascia cadere, come se niente fosse: “in fondo il mio percorso di cineasta va dalla sociologia all’ontologia”. Nessuno raccoglie.
Le domande insistono piuttosto sugli attori, sulle loro relazioni, sulla maniera di rappresentare il disagio sociale. I protagonisti sono una vera coppia marito-moglie e il film è così convincente che una donna chiede se i due vivessero davvero una crisi, se fossero davvero poveri. Alla fine Tarr lo dice apertamente: “è un falso documentario, tuttavia ciò che mostra è vero!”.
In effetti, nei due giorni ginevrini di Béla Tarr la questione in gioco è soprattutto il rapporto tra realtà e finzione, una contraddizione che il regista non scioglie mai, anzi assume in pieno. La verità di un film non è in ciò che racconta, ma nell’intenzione dei suoi artefici. La scelta del bianco e nero, innanzitutto, è una dichiarazione di onestà: se vediamo un’immagine a colori, ci immedesimiamo di più che davanti alle scale di grigio. Il mondo è a colori, il bianco e nero è artificio, anche se si tratta di un artificio che lascia liberi di concentrarsi su ciò che più conta: la luce, le sfumature, le ombre, i suoni. Gli attori recitano, certo, e sono pagati per farlo, ma un bravo regista non è altro che “uno sporco cacciatore di emozioni” e la sua abilità è quella di spostare la macchina là dove sta succedendo qualcosa di importante, che non è sempre azione, ma magari solo uno sguardo. E se si insiste abbastanza a lungo su quella inquadratura, su quegli occhi, su quella luce, la recitazione dell’attore passa in secondo piano e si può arrivare a cogliere una briciola dell’essenza di quell’essere umano. “Verità uguale finzione più tempo” è la bizzarra equazione che trovo annotata sul mio taccuino il giorno dopo, ma non so se ha un senso.
Quel che è certo, è che il cinema di Béla Tarr è pieno di finzioni. Gli scrittori possono prendersi venti pagine per descrivere un oggetto, ma il regista, per renderlo “concreto”, non ha che qualche fotogramma, e allora deve studiare bene le luci, l’inquadratura, i suoni. Per creare un effetto di realtà sullo schermo, egli deve “esagerare” la realtà stessa. Un nuovo video mostra il making of di una scena di The Turin Horse: un elicottero si alza in volo per imitare un vento furioso, gli assistenti lanciano manciate di foglie secche sui protagonisti e strattonano i rami dell’albero per farne cadere altre ancora, la camera sistemata all’altezza del suolo, “come faceva Ozu”, aumenta la profondità di campo, la fotografia ricrea la luce bassa e forte di un inverno perenne.
Inesorabili, gli svizzeri continuano con i clip. Stavolta è il commovente piano sequenza dell’ospedale di Werckmeister Harmonies, e Tarr lo commenta così: “una vera merda”. Qualsiasi regista di Hong-Kong sa fare di meglio, afferma, gli errori restano a suo avviso evidenti anche se l’ha girata almeno sette volte, “eppure, nello stesso tempo, è esattamente quello che volevo”, chiosa. Il cinema action/stop non gli piace, è solo una bugia. Ogni volta che diciamo “stop” mentiamo, perché il tempo non si ferma mai. Per questo, a volte, Tarr cerca di “giocare col tempo”: sposta la camera dall’azione principale, che continua a svolgersi, per andare altrove, per mostrare altro, perché non solo l’azione non si ferma mai, ma un sacco di cose interessanti accadono nello stesso istante e il regista non deve far altro che trovarle e filmarle. “Fare film è molto semplice”, afferma, basta trovare una cosa che ti interessa e metterci la camera davanti. E lasciarcela finché qualcosa accade, finché non si sente che quel qualcosa è finito e che ci si può finalmente spostare. La cosa difficile è un’altra: essere onesto, sincero, forte, farsi rispettare dai produttori, né lasciarsi sedurre, non cambiare idea, continuare sulla propria strada, fino in fondo.
Ed a questo fine, “le scuole di cinema sono inutili”, dice accorgendosi subito della gaffe e iniziando quindi a ridacchiare. Il suo intervistatore è difatti il direttore del dipartimento di cinema della Head e gran parte del pubblico è composto dai suoi studenti. Stavolta è l’intervistatore a stizzirsi: “ma anche lei ha una scuola”, dice maligno. “Sì, ma io imbroglio”, è la replica. La scuola, Tarr l’ha messa su per ottenere dei soldi per i giovani cineasti, gli esami e i corsi sono finti: “io non insegno niente, li incoraggio a cercare la loro strada e li lascio completamente liberi”.
La conclusione di entrambi gli incontri finisce inevitabilmente per essere la stessa: “perché non farà più film?”. E anche la risposta è la stessa: “l’ho già detto un sacco di volte, cercate su Google”. Ma poi una replica gli scappa, quando una ragazza gli chiede di ripeterlo ancora: “ma solo perché me lo chiede una signora”.
Voleva cambiare il mondo, Béla Tarr, ma tutto quello che ha cambiato è stato il linguaggio cinematografico. Meglio, ha detto ciò che sentiva, nella maniera che gli sembrava migliore, forse ha creato addirittura un suo proprio linguaggio e poi lo ha purificato e perfezionato fino a che ha “sentito che la sua opera era completa”. Fare altro significherebbe ripetersi, copiarsi, citarsi. Non che ci sia niente di male, dice, ma lui non vuole pensare al cinema come a un “gioco bourgeois”; e questo soprattutto per rispetto allo spettatore. Quando fa un film, Tarr immagina degli spettatori “molto più intelligenti e sensibili” di lui: questo lo spinge a fare del suo meglio, a evitare a ogni costo l’entertainment.
Con effetto studiato, Jean Perret fa abbassare le luci e lascia scorrere le immagini finali di Damnation mentre si levano fragorosi gli applausi. Ma, nonostante il baccano, io che sono in prima fila, sento distintamente: “Ecco appunto l’entertainment. Senti, io ‘sto film già lo conosco, posso uscire a fumare?”.