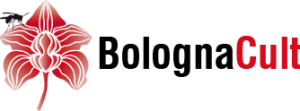IN BREVE Cosa: The Irishman (Martin Scorsese 2019) e Parasite (Bong Joon-ho 2019), una recensione
 Una cosa strana di The Irishman (Martin Scorsese 2019) è che per la maggior parte del film si osservano protagonisti moderatamente vecchi, che si muovono con i gesti circospetti e rallentati di uomini parecchio più vecchi. Anche gli sguardi, sotto la computer grafica, tradiscono la realtà dell’epica rosa di attori – Pacino, De Niro, Pesci – costretti a negare il loro essere a un passo dagli ottanta. La sensazione di dover ricostruire in ogni scena le sembianze reali dell’attore, e confrontarne la versione ringiovanita con quella reale della stessa età, che tutti conosciamo, mi ha accompagnato per tutto il film, e non è una cosa che aiuta.
Una cosa strana di The Irishman (Martin Scorsese 2019) è che per la maggior parte del film si osservano protagonisti moderatamente vecchi, che si muovono con i gesti circospetti e rallentati di uomini parecchio più vecchi. Anche gli sguardi, sotto la computer grafica, tradiscono la realtà dell’epica rosa di attori – Pacino, De Niro, Pesci – costretti a negare il loro essere a un passo dagli ottanta. La sensazione di dover ricostruire in ogni scena le sembianze reali dell’attore, e confrontarne la versione ringiovanita con quella reale della stessa età, che tutti conosciamo, mi ha accompagnato per tutto il film, e non è una cosa che aiuta.
The Irishman, dunque, è un film apologetico, più che nostalgico o crepuscolare, che invece di un capitolo finale prova a mettere in scena, nell’imponenza delle sue tre ore e mezza, un punto fermo nel genere. Purtroppo, senza riuscirci. Anche lo script sembra una ricostruzione posticcia, e quasi ogni scena, più che mostrare sé stessa, sembra rimandare all’espressione omologa dell’epoca d’oro, già pienamente elaborata, memorizzata e catalogata nei dolci e violenti stilemi del cinema. La regia offre grandi sprazzi di eleganza, e la concatenazione fra le scene e gli episodi è fluida e immancabilmente sapiente. L’intreccio, però, non trova un motore convincente, e neanche il caos diabolico di The Wolf of Wall Street, mentre si affaccia, in alcuni toni, la noia autoindulgente di Silence che male si accorda alle aspirazioni del nostro, che ovviamente hanno Goodfellas come principale modello. Non credo sia da assecondare, d’altra parte, la gran voglia di etichettare questo film come “testamento d’artista”: Martin lotta insieme a noi portando costantemente avanti una quantità di progetti interessanti (di poche settimane fa il nuovo film doc su Dylan), quindi questo è un caloroso “alla prossima”.
voto: 3 su 5
 Ci sono occasioni in cui una parte consistente della critica e del pubblico sembra ritrovarsi all’anno zero del cinema. È il caso di Parasite, film appena apprezzabile, in cui si è voluto trovare uno stravolgimento dei generi e del linguaggio. Parasite è un’espressione abbastanza standard del cinema coreano, fatto di passaggi ruvidi imposti dall’egemonia di una tesi narrativa (spesso troppo ingombrante), resi artistici, a volte poetici, dai silenzi e dalla freddezza e immediatezza dello sguardo. È un cinema che, con diversi risultati, da decenni sovrappone i generi, più che ibridarli, e riporta una violenza atona come elemento più rappresentativo e connaturato dell’essere umano.
Ci sono occasioni in cui una parte consistente della critica e del pubblico sembra ritrovarsi all’anno zero del cinema. È il caso di Parasite, film appena apprezzabile, in cui si è voluto trovare uno stravolgimento dei generi e del linguaggio. Parasite è un’espressione abbastanza standard del cinema coreano, fatto di passaggi ruvidi imposti dall’egemonia di una tesi narrativa (spesso troppo ingombrante), resi artistici, a volte poetici, dai silenzi e dalla freddezza e immediatezza dello sguardo. È un cinema che, con diversi risultati, da decenni sovrappone i generi, più che ibridarli, e riporta una violenza atona come elemento più rappresentativo e connaturato dell’essere umano.
Parasite, in una struttura ampia e ambiziosa, riporta il confronto fra poveri e ricchi, fra abitazioni sotterranee allagate dai liquami e architetture perfette, impeccabilmente contemporanee. Le metafore inseguono la loro esplicitazione, lasciando corrispondere i luoghi alle persone e le persone ai loro difetti, disseminando prevedibili imprevedibilità e adottando nelle svolte principali soluzioni pretestuose e, in contrasto con la ricercatezza estetica e formale, a volte rozze. La componente grottesca, che con furia travolge i più poveri rendendoli ovvi e inetti, spazza via qualsiasi plausibile lettura che trovi nel film un nucleo di critica o impegno sociale. Parasite è un film formalmente complesso, effettivamente semplicistico.
voto: 3 su 5