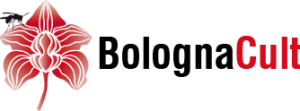IN BREVE Cosa: La Casa di Jack – The house that Jack built, una recensione Regista: Lars von Trier Protagonisti: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman Dove: al cinema dal 28 febbraio 2019
 La Casa di Jack mi ha lasciato un senso di disagio nelle ore successive alla visione – opportuno, dal momento che solo un’anima affine a quella del protagonista potrebbe non provarne -, poi poco altro. Nonostante sia un’opera ambiziosa e radicale. Per il suo nuovo film, Lars von Trier prende da quelle che – per la mia esperienza – sono i suoi film peggiori. L’accanimento, la reiterazione morbosa da Dancer in the Dark, le aspirazioni enciclopediche da Nymphomaniac. Qui traslate da eros a thanatos, e per i corpi e la putrefazione, per la digressioni iconiche e letterarie, per l’architettura e la musica, ancora più vicine alla lezione di Peter Greenaway. Il tema, ma anche il gelo estetizzante e la grana del racconto, ricordano inoltre il John McNaughton di Henry, Pioggia di Sangue.
La Casa di Jack mi ha lasciato un senso di disagio nelle ore successive alla visione – opportuno, dal momento che solo un’anima affine a quella del protagonista potrebbe non provarne -, poi poco altro. Nonostante sia un’opera ambiziosa e radicale. Per il suo nuovo film, Lars von Trier prende da quelle che – per la mia esperienza – sono i suoi film peggiori. L’accanimento, la reiterazione morbosa da Dancer in the Dark, le aspirazioni enciclopediche da Nymphomaniac. Qui traslate da eros a thanatos, e per i corpi e la putrefazione, per la digressioni iconiche e letterarie, per l’architettura e la musica, ancora più vicine alla lezione di Peter Greenaway. Il tema, ma anche il gelo estetizzante e la grana del racconto, ricordano inoltre il John McNaughton di Henry, Pioggia di Sangue.
Un bravo Matt Dillon è un ingegnere a tempo perso, psicopatico a tempo pieno. Dopo la depressione e l’ossessione per il sesso di Nymphomaniac, veniamo introdotti alle abitudini del serial killer Jack attraverso un altro problema psichico, il disturbo ossessivo compulsivo. Sindrome – qui subito nobilitata dalle apparizioni d’archivio di Glenn Gould – che suscita sempre una certa simpatia e che in forma blanda di solito piace sfoggiare. Poi accantonata in favore di un discorso più discontinuo che tocca vari temi, come la definizione dell’arte, l’impatto della stessa e l’applicazione negli hobby omicidi di Jack, la storia e lo stato dell’essere umano: solo davanti all’orrore e, dall’altro punto di vista, sostanzialmente privo di empatia. Von Trier racconta tutto questo (e ci sono davvero tante cose, nel film) adottando un tono spesso sarcastico, anche lezioso e autoindulgente nelle estremizzazioni didascaliche.
The House that Jack Built è un film enciclopedico, ma dal respiro corto, concentrato soprattutto sulla creazione di una visione antologica dei temi e le opere del regista (fra l’altro, tutte citate direttamente in un montaggio veloce). I quadri raggelati con cui si aprono Antichrist e Melancholia qui compaiono in chiusura, a suggellare un richiamo dantesco piuttosto ripetuto (ma che ha il pregio di accogliere l’ultima interpretazione di Bruno Ganz, nei panni di Virgilio), e anche il pezzo sui titoli di coda, una chiusura rock in contrasto con l’epilogo, riprende i titoli finali di Dogville su Young Americans.
Il danese, a ogni modo, è vanitoso ma elegante, trova dei buoni momenti di sceneggiatura e soprattutto sfoggia una padronanza del mezzo filmico che nella contemporaneità ha pochi rivali. “L’arte non deve essere sincera, ma deve dire la verità”, recitava Manifesto, bel film di Julian Rosefedt che pure riflette apertamente sull’uomo e la cultura. E qui, forse, von Trier si dedica a mettere in scena quanto – per quel che è diventato – crede sia necessario esprimere, e non dice più la verità.
voto: 3,5 su 5