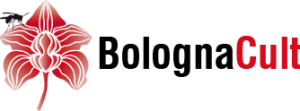Continuano le nostre interviste con i principali protagonisti delle scelte culturali della programmazione bolognese. Oggi è il turno di Stefano Casi, direttore artistico di Teatri di Vita, una delle realtà più sperimentali della città, che da anni con la sua struttura al Parco dei pini si propone pasolinianamente di proporre uno sguardo dove gli altri non guardano, con un interesse molto preciso sui temi politici di stretta attualità.
Teatri di Vita sceglie un titolo fortissimo per questa seconda parte di stagione: Recito di cittadinanza. Ci spieghi i motivi di questa scelta molto evocativa?
Abbiamo giocato con uno dei termini più forti della politica degli ultimi mesi, diventato uno slogan alla fine un po’ vuoto ma roboante per nascondere un banale sussidio di disoccupazione. Ma nel gioco ironico sta invece una chiave di volta di ciò che riteniamo la funzione del teatro, e cioè il dialogo con l’attualità, l’essere opportunità di riflessione e rispecchiamento della realtà che ci circonda. Quindi, si “recita di cittadinanza” per dire che si fa teatro per riflettere la nostra consapevolezza e la nostra responsabilità in ciò che accade attorno a noi, nella “città” e nel nostro essere cittadini, nella società e nel nostro esserne parte.
Il manifesto della stagione ha un richiamo sovietico. Scatta automatica la domanda: cosa ha sbagliato la cultura di sinistra in questi anni per produrre una società oggi così lacerata e superficiale?
Sì, si tratta di un’immagine rubata a un vecchio manifesto dei primi anni di Unione Sovietica, in cui si vede un uomo bendato camminare sull’orlo di un precipizio. Ciò che gli impedisce di vedere è l’ignoranza, l’analfabetismo, la mancanza di cultura: era un invito a studiare e conoscere, e noi l’abbiamo preso, anche con ironia, per ricordare che la cultura e la conoscenza possono sollevare la benda che impedisce alle persone di prendere le decisioni giuste.
In effetti, oggi, fa riflettere amaramente il fatto che cultura e sinistra siano sempre stati due termini fortemente intrecciati, ma che poi questa simbiosi non abbia saputo tramutarsi in reale capacità di determinare un’evoluzione della società. Contrariamente ai tanti mea culpa della sinistra che sento masochisticamente e superficialmente rimbalzare in continuazione, credo che la responsabilità maggiore della lacerazione e della superficialità della società attuale stia (pasolinianamente?) nel trionfo del consumismo. Che nessuna forza di sinistra sarebbe stata in grado di vincere, ma solo di arginare appena. È il consumismo ad aver innescato un sistema di valori e di meccanismi e una produzione di oggetti (e loro relativo uso) che stanno alla base dei grandi movimenti di massa oggi, talmente radicato da determinare l’imprinting delle nuove generazioni ormai da tempo. Ma qui il discorso si fa immensamente più complesso e non procedo.
D’altra parte, se la sinistra ha sbagliato, cosa dire della Chiesa? Faccio notare che la nuova ondata egoistica, xenofoba e razzista che sembra essere maggioranza oggi nel Paese, più che mostrare il fallimento della cultura di sinistra mi sembra che mostri il fallimento della Chiesa nel suo essere guida spirituale. E allora, cosa ha sbagliato la Chiesa per vedere come i fondamenti minimi del suo essere (“ama il prossimo tuo come te stesso” che è il minimo indispensabile di ogni cristiano) vengono sbeffeggiati dagli italiani sedicenti cattolici? Al netto dei suoi errori, che anche la Chiesa ha avuto nella sua storia ambigua, mi sembra evidente che il punto non stia nell’andare a vedere le colpe dei perdenti, ma le armi dei vincenti: il consumismo, appunto, cioè ciò che ha spostato l’asse valoriale dalla persona all’oggetto, con le mille conseguenze di un egoismo gretto per ciò che abbiamo e che non vogliamo spartire con chi è più bisognoso di noi. Non era (ancora!) Pasolini che già 45 anni fa aveva con precisione cristallina individuato nella vittoria del consumismo l’inizio della fine della Chiesa come guida spirituale, nel famoso articolo sui jeans Jesus?
“Il discorso di genere è politico
e non ci può essere discorso politico
senza attenzione
alla questione di genere”
Riflessione Politica e riflessione di genere, come spesso accade nella vostra programmazione, si intrecciano profondamente. Con quale approccio rispetto a questi due discorsi avete pensato a questa stagione?
Per noi le due riflessioni vanno assolutamente di pari passo. Il discorso di genere è politico e non ci può essere discorso politico senza attenzione alla questione di genere, così come a quella sulle minoranze e sulle differenze. Per questo, insistere tanto, come facciamo noi, su alcuni aspetti come la riflessione di genere è importante, nel momento in cui l’attenzione sulla persona deve stare alla base di ogni discorso politico. Anche in questo caso, la “cittadinanza” ha senso in relazione a una politica che assume una riflessione sul genere, sulle minoranze e sulle differenze. Ci sono diversi spettacoli in stagione che richiamano questo discorso, e il richiamo è inevitabilmente sempre politico, da “Rosa Winkel” sugli omosessuali internati nei lager nazisti a “Abracadabra” che rievoca la figura di Mario Mieli e la sua proposta che dal “gaio comunismo” arriva a quella di una transessualità come liberazione universale della persona.
Nella prima parte avevate invece approfondito lo sguardo sul tema violenza di genere. Quali sono stati gli spettacoli che vi hanno dato un ritorno più forte col pubblico?
La prima parte era dedicata a “Femminile tangenziale”, quindi con uno sguardo un po’ più ampio sulla questione di genere, che ha offerto molti spunti. Da questo punto di vista, oltre a “Bello mondo” di Mariangela Gualtieri, che ha anche vinto il Premio dello Spettatore 2018 (ex aequo con “Fa’afafine” di Giuliano Scarpinato, altro spettacolo importante sull’identità di genere e sull’accettazione delle differenze, che abbiamo presentato agli inizi dell’anno), hanno toccato sicuramente spettacoli come “La chiave dell’ascensore” di Agota Kristóf, diretto da Fabrizio Arcuri, dove emerge come la violenza sulla donna sia prima di tutto psicologica (cosa che è stata a lungo dibattuta nell’incontro post-spettacolo della domenica), e “La ianara” di Licia Giaquinto, intepretata da Elisabetta Aloia, che ancora una volta porta in primo piano una figura femminile contro i pregiudizi.
A proposito di pubblico: qual è l’identikit dello spettatore di Teatri di Vita? Nella città che cambia avete notato una variazione nella composizione degli spettatori o avete un’identità culturale così forte da essere scelti da un pubblico omogeneo?
Il criterio di omogeneità del pubblico di Teatri di Vita consiste nella curiosità che accomuna tutti i nostri spettatori e nella loro apertura verso temi e suggestioni come quelle di cui abbiamo parlato. Ma per il resto non esiste un “tipico” spettatore di Teatri di Vita, se con questo mi dovessi riferire all’età o ad altri criteri, complice anche la profonda differenza degli spettacoli che presentiamo, in nome di una pluralità di sguardo che ci portiamo addosso a partire dal nome stesso di Teatri di Vita.
Domanda classica: come sta il teatro italiano e come sta il teatro a Bologna?
Domanda fin troppo classica, e perciò a rischio di ricevere risposte classiche. Oppure di essere trattata come un classico, declinabile diversamente ogni volta ma con costanti astoriche che la rendono inossidabile. Scherzi a parte, credo che il teatro italiano stia bene e male al tempo stesso. Bene perché la qualità e il coraggio non mancano, anzi: e anche il programma di “Recito di cittadinanza” lo dimostra. Male perché il teatro continua a non essere considerato elemento determinante della vita di questo Paese dalle istituzioni e a ricaduta dall’opinione pubblica generale (o viceversa). Non solo l’investimento economico è basso (solo dalle nostre parti la Regione Emilia Romagna e il Comune di Bologna hanno saputo riconoscere nella cultura e nel teatro un terreno importante di nutrimento e coesione sociale, e quindi ci investono sapendo che l’investimento ha un riscontro ben maggiore e importante per la comunità), ma basti pensare alla farsa del Codice dello Spettacolo per rendersene conto. E vale la pena raccontarlo perché purtroppo non se n’è parlato. Succede che nel dicembre 2017 viene finalmente varata dal governo di centrosinistra la prima legge sul teatro in Italia (ebbene sì: per 70 anni la nostra Repubblica non aveva mai varato una legge specifica sul teatro, al contrario della musica o del cinema per esempio), che impone la realizzazione di decreti attuativi entro il 27 dicembre 2018 pena la decadenza della legge. Il governo Gentiloni in 3 mesi non fa nulla perché in scadenza (e quindi come atto di “cortesia” nei confronti del successivo). Il nuovo governo Lega-5Stelle, in carica dal primo giugno, prima promette di fare i decreti, poi – quando si rende conto che è rimasto poco tempo – promette di varare una proroga della scadenza. Ebbene, nonostante le reiterate promesse di proroga e rassicurazioni, non fa assolutamente nulla, e quindi la legge varata dopo 70 anni di attesa si è semplicemente… vaporizzata per l’ignavia della classe politica che in 6 mesi non è riuscita non dico a fare i decreti, ma neanche una banalissima proroga. L’ubriacatura del reddito di cittadinanza ha fatto dimenticare il “recito di cittadinanza”, mi viene da dire. Mi sembra la dimostrazione perfetta di come la politica consideri il teatro. O qualcosa di inutile o di dannoso per il Potere: in ogni caso qualcosa che non è degno neanche del più banale e usato provvedimento burocratico italiano: la proroga.