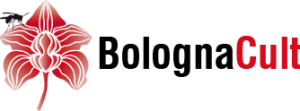IN BREVE Cosa: recensione di “The other side of everything” Regia: Mila Turajlić
“The other side of everything” (titolo originale: Druga strana svega) di Mila Turajlić è stato proiettato martedì 6 novembre alla Cineteca di Bologna, nell’ambito della selezione ufficiale del LUX Prize, progetto promosso dal Parlamento europeo che incentiva la realizzazione di film sulle istanze socio-politiche europee.
Mila Turajlić sottolinea l’animo intimista del suo documentario e delimita da subito il suo campo d’azione nel voler parlare della Serbia e di Belgrado da un punto di vista estremamente personale, ma mai solipsistico. Dall’appartamento di sua madre, ma con le finestre sempre aperte, segue le diverse situazioni che si avvicendano in strada, senza la volontà di realizzare un affresco storico esauriente.
La regista ha voluto tenere accesa la sua telecamera per quasi 10 anni, al riparo dietro i vetri dell’appartamento, perché – come più volte spiega – parlare del suo paese significa parlare di spazi divisi, come l’interno e l’esterno di un palazzo.
Ma il documentario non è il suo personale atto di resistenza. Il film di Turajlić è “solamente” il suo modo per dire che non le resta che distanziarsi dalla situazione politica serba; è l’ammissione di non riuscire a fare di più per il suo paese, se non immortalare le parole dissidenti e la veemenza di sua madre.
Un film che incarna una sorta di passo indietro della regista. Lo dice in un’intervista dopo la proiezione, dando ancora più risalto al fatto che quello che consegna al pubblico, tremante, è un oggetto d’arte e non un velleitario prodotto di impegno politico che si avvale del lessico cinematografico.
La madre di Mila, Srbijanka Turajlić, ha un viso impertinente, capelli bianchi e cortissimi scomposti e una corporatura possente. Nella prima scena è intenta a lucidare l’argenteria e invita la figlia a riprendere il lavoro certosino che sta facendo.
Srbijanka è una professoressa universitaria di matematica in pensione e un’attivista politica, passioni complementari nella sua ottica di impegno civico a tutto tondo. Licenziata nel 1999 per visioni politiche eterodosse, dal 2001 al 2004 viene però chiamata a collaborare al Ministero dell’Istruzione Superiore dal nuovo governo democratico insediatosi dopo la caduta di Milošević.
È un personaggio dallo spessore arendtiano, capace di un’acutissima intelligenza filosofico-politica, che riesca a declinare tanto nei comizi in piazza quanto alle serate istituzionali.
È il suo carisma a dominare il film: la regista, sua figlia, racconta che, in principio, era intenzionata a focalizzare il documentario sul rilievo metaforico delle porte chiuse dell’appartamento di famiglia, le quali ricordano costantemente l’epoca di partizione comunista degli immobili della borghesia, nel 1929. Aggiunge ridendo che lo spazio occupato da sua madre si è mano a mano andato allargando e ciò l’ha portata a ricalibrare l’intero film su questa donna, ingombrante per il paese e quasi scomoda per la famiglia.
Un film che ha cambiato fuoco prospettico diverse volte. La regista, infatti, in una scena racconta proprio alla vicina di casa, Nada Bezarevic, che sta pensando di montare un documentario sul palazzo in cui vivono, costruzione voluta dal bisnonno Dušan Peleš (un illustre firmatario dell’atto di unificazione nazionale nel Regno di Serbi, Croati e Sloveni nel 1918).
Il grosso del lavoro è però stato fatto nel 2015 durante le elezioni serbe, in un paese che sembra essersi dimenticato l’euforia e la responsabilità del 5 ottobre 2000, la sera in cui tanti serbi a Belgrado si erano domandati l’uno l’altro: “Siamo sopravvissuti a Milošević. Riusciremo ora a sopravvivere alla democrazia?”. Il 5 ottobre 2000: il giorno in cui centinaia di migliaia di persone protestarono di fronte al Parlamento serbo, facendo successivamente irruzione nel palazzo a causa degli ennesimi brogli per mano di Milošević.
Il parallelo tra le porte chiuse e le vicende d’attualità in Serbia, parallelo che la regista ha voluto portare avanti per tutta la durata del documentario, viene meno proprio nel finale dove, invece di un climax, ci si trova dinanzi a un anticlimax.
In una delle poche scene finzionali del film, i vari personaggi sono immobili, in attesa davanti alla porta che viene finalmente aperta. Ma l’emozione – sia diegetica che nel pubblico – fatica ad arrivare.
Non c’è emozione perché non c’è vera catarsi quando le porte sigillate vengono aperte, perché non esiste più, a questo punto, il filo rosso della metafora. Le stanze nascoste sono parte dell’eredità che Srbijanka vuole lasciare alle figlie e ha dovuto compilare dei fogli affinché fossero riconosciute le planimetrie antecedenti l’epoca comunista.
È un finale che non si lascia dire positivo, anche per le vicende che vedono coinvolta Srbijanka Turajlić nelle ultime scene. Alla vigilia delle elezioni politiche del 2015, la ex professoressa viene invitata a comparire in tribunale in quanto il suo nome compare nella lista di traditori e nemici della nazione.
La sua vicenda personale può anche avere esito positivo (e come spettatori non ci è dato saperlo), ma una vita singola non ha in sé alcun valore assoluto se in un contesto sociale non vi è progresso, ma conservatorismo e regresso. Per dirla con le parole di Srbijanka: “Se costruisci la tua vita ignorando le circostanze esterne, non ti renderai conto del momento in cui quelle circostanze cambiano drammaticamente la vita tua e degli altri intorno a te”.
Mentre la madre esce di casa, la regista si raccomanda: “Non lasciarti provocare”. Lei sorride sorniona alla telecamera e richiude la porta dietro di sé: è tornato anche per lei il tempo di scendere in strada, nell’arena politica.