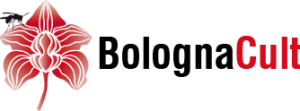IN BREVE Cosa: Star Wars Gli ultimi Jedi, una recensione Quando: in sala dal 13 dicembre 2017 Regia: Rian Johnson Interpreti: Daisy Ridley, Mark Hamill, Adam Driver, Carrie Fisher
Proverò a farla breve, anche se sono tanti i motivi, sentimentali ed estetici, per cui Star Wars: Episodio VIII: Gli ultimi Jedi segna la fine della giovinezza e l’ingresso nel franchising. Premessa sull’autore: da Brick, a Brothers Bloom, a Looper, era chiaro come Rian Johnson praticasse un cinema mimetico, ricalcando diversi generi e autori anche con discreta capacità, ma senza lasciare intravedere una cifra personale. Qui le cose non migliorano. Johnson tratta Star Wars come se la saga fosse un genere in sé, ne insegue i canoni e contemporaneamente sente l’esigenza postmoderna di provare a stravolgerli. Ma l’idea, tutt’altro che insensata, viene eseguita inserendo nel mondo di Guerre Stellari elementi estranei, senza provare ad adattarli, con la conseguenza principale di portare tutto nella banalità del linguaggio comune al cinema mainstram.
Dopo il remake / reboot per le nuove generazioni di Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi ha il compito di adeguare definitivamente la struttura alla lunga serialità, con il moltiplicarsi dei personaggi e delle storie e la minimizzazione in entrambi del respiro epico, il proliferare di episodi aperti anche all’interno del singolo film, l’idea che ogni titolo possa avere un’impostazione differente, essendo una variazione sul tema dei gusti del pubblico. Insomma l’adesione al modello Marvel. Con Episodio VIII si estingue la vecchia generazione di eroi, e si fa davvero poco per dare interesse ai nuovi, anche in funzione di un ricambio che sappiamo sarà metodico, da una trilogia all’altra, da uno spin-off all’altro, fino alla fine dei tempi.
Nell’epica, la semplicità ha una sua importanza. Devono essere chiari i ruoli degli attanti e chiare quanto ambiziose le loro missioni, che devono rispecchiare qualcosa che non solo è scritta nel destino, ma è stata incisa in poche parole e a caratteri grossi. Difficile pensare che da qualche parte, nel destino, fosse scritto che dovessimo interessarci a un’astronave ferma nello spazio senza benzina. Eppure per una metà del film il centro è quello, mentre si porta all’interno della saga un racconto laterale, sulla linea di Rogue One, e lo si porta in un mondo alla Grande Gatsby, mentre Finn e una tizia mai vista vanno alla ricerca di un tizio mai visto.
Anche nell’estetica, la semplicità ha la sua importanza. Qui probabilmente c’entra l’anagrafe, ma sono propenso a credere che il modo di trattare l’azione, nel passaggio dall’analogico al digitale, abbia subìto un decadimento oggettivo. Quando alle cose devi prenderti la briga di dare una sostanza concreta, è probabile che nella scena abbiano un loro spazio e una loro funzione. Da Star Wars alle varie vicende supereroiche, a tutte le scene numeriche concitate che tendono a scivolare via, l’unica preoccupazione sembra essere quella di riempire il quadro in ogni suo centimetro, portando lo sguardo in percorsi implausibili per una macchina da presa, e di fatto cancellando la presenza dello spettatore. Non dico che tutto questo non possa funzionare, se si è cresciuti con una visualizzazione normalmente strutturata in questo modo, ma credo si tratti, per la narrazione e le sue modalità di visualizzazione, di un impoverimento effettivo e di una generale perdita di necessità e identità.
In conclusione, due rivendicazioni. La prima per Blade Runner 2049, che deve la sua riuscita alle cose per cui è stato spesso criticato, ovvero per il suo incarnare un film soprattutto d’osservazione, che gestisce i tempi senza essere ossessionato dall’essere costantemente funzionale allo spettacolo e a una trama che, purtroppo, si avvierà anche quella all’anonima serialità (se davvero avrà un seguito). La seconda per la trilogia di George Lucas che, pur con tutti i suoi errori, nasceva ancora da passioni e idee.
Non l’ho fatta brevissima, ma avrebbe potuto andare peggio.
voto: 2,5 su 5